A cura dell'avvocato Salvatore Scognamiglio del Foro di Napoli
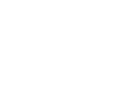
A cura dell'avvocato Salvatore Scognamiglio del Foro di Napoli
Ad Anna e Luigi,
che sappiano affrontare
con gioia e determinazione
il lungo e difficile viaggio della vita..
Donne vittime di stalking: perché denunciare
Moltissime donne vittime di stalking spesso sottovalutano quei segnali che preannunciano il pericolo; sopportano le sofferenze più indicibili, i
soprusi e le mortificazioni peggiori ma non denunciano, con esiti – come la cronaca quotidiana inesorabilmente dimostra - spesso fatali.
Le ragioni di questo comportamento sono molteplici: spesso non si denuncia per paura di ritorsioni da parte del proprio ex compagno; altre volte
la vittima ha letteralmente vergogna di esternare il proprio vissuto, fatto di umiliazioni e di prevaricazioni di ogni tipo da parte del marito o
dell'ex compagno; non è infrequente che sia la stessa vittima che - nonostante tutto – non volendo distruggere quello che rimane della famiglia,
rinuncia a far valere i suoi diritti; altre volte si desiste per non vedersi azzerare le fonti di reddito...
Questo stato di cose è certamente favorito da una informazione non corretta anche se – va detto - passi in avanti sono stati fatti rispetto al
passato.
Purtroppo, infatti, tantissime donne vittime di atti persecutori - in totale buona fede - ignorano che attualmente la legislazione vigente offre
un'ampia gamma di misure a loro sostegno.
Occorre infatti chiaramente ribadire che le istituzioni pubbliche, le forze dell'ordine e soprattutto i presidi sanitari ( le Asl di appartenenza) che
ricevono dalla vittima la notizia di reato di stalking, hanno l'obbligo di fornire alle stesse tutte le informazioni utili ed indispensabili relativamente
ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nei pressi della residenza.
Le donne vittime di stalking se rassicurate sin da subito – durante il primo contatto – e protette saranno certamente incoraggiate a denunciare.
L'assistenza dei centri antiviolenza è a 360° ( compresa l'assistenza con gratuito patrocinio) ed è di fondamentale importanza rivolgersi
immediatamente ad essi: rimandare la denuncia servirà soltanto a complicare il problema fino ad esiti sel tutto imprevedibili... con l'aiuto dei
centri di ascolto ed orientamento e l'assistenza di avvocati esperti della materia i problemi, anche se spesso di natura molto complessa, si
possono risolvere prima ancora di affrontare la questione in sede giudiziaria ( con tutto lo stress che ne deriva per la già vessata vittima di
violenza).
( Vietata la riproduzione)
Brevi cenni in tema di responsabilità penale del titolare d'impresa e problema della delega di funzioni
Avv. Salvatore Scognamiglio 24.12.2018
L'argomento che ci occupa riveste particolare importanza, specie con riferimento agli ultimi fatti di cronaca e merita un'attenta analisi atteso anche il particolare rilievo che alla fattispecie è stato dato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti.
La problematica della responsabitità penale del soggetto che riveste una posizione apicale nell'ambito di una società di grosse dimensioni investe anzitutto la fattispecie dell'omissione ed in particolare la fattispecie dell'omesso impedimento di un evento attesa la posizione di garanzia ricoperta dall'imprenditore.
Ai sensi dell'art.40 cpv del c.p. non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Dunque, in base alla legge penale italiana, quando può dirsi che sussiste l'obbligo di impedire l'evento da parte del titolare dell'impresa?
Va subito precisato che ciò che rileva, ai fini della responsabilità penale del titolare-soggetto apicale è soltanto l'omesso compimento di un'azione impeditiva dell'evento previsto da una norma giuridica.
Il soggetto agente, pertanto, si pone come garante dell'integrità di uno o più beni giuridici dovendo egli impedire che si verifichino i pericoli innescati dai comportamenti di terzi o da forze della natura ( es. posizione dei vertici della società concessionaria autostradale nel caso di crollo di viadotti, strade, autostrade ecc. ecc.).
Nel caso particolare che qui viene in evidenza siamo dunque nell'ambito dei c.d. atti di controllo che hanno ad oggetto la neutralizzazione di pericoli connessi allo svolgimento di attività umana ed in particolare ai pericoli per l'incolumità pubblica connessi alla circolazione su strade e autostrade in concessione ad Enti e/o società miste.
Infatti, come oramai pacifico in dottrina e in giurisprudenza, gli obblighi di controllo incombono su quei soggetti che si pongono ai vertici dell'impresa ed ai quali la legge affida il compito di organizzare l'attività d'impresa salvaguardando gli interessi di tutti i consociati.
Tuttavia, date le grosse dimensioni degli Enti di cui sopra, un ruolo delicato e fondamentale è qui giocato dal c.d. conferimento della delega di funzioni ai dirigenti sottoposti al titolare in posizione di vertice; dovendosi qui rispondere al fondamentale quesito se la delega di funzioni comporti o meno un totale trasferimento degli obblighi di garanzia dal soggetto apicale agli altri dirigenti delegati.
Sulla base degli arresti giurisprudenziali più recenti va detto che un dovere di vigilanza sul rispetto dei compiti assegnati sussista comunque in capo ai vertici dell'impresa, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 2381 c.6° e 2392 c.2° c.c.: dovere di impedire fatti dannosi o pericolosi quando essi vengono a conoscenza dell'esistenza di rischi in atto.
Pertanto, se il P.M. - in un eventuale dibattimento - riuscirà a fornire elementi di prova che il soggetto apicale era a conoscenza di fattori di rischio opportunamente segnalati ( ad. es. attraverso relazioni tecniche sullo stato dei luoghi, come nel caso di viadotti) quest'ultimo, in caso di omesso o insufficiente controllo, dovrà rispondere in concorso con gli autori ( es. dirigenti delegati) per omesso impedimento di reati – dolosi o colposi- commessi da terzi nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Tuttavia, in caso di società di grosse dimensioni, con suddivisione in settori, rami e servizi, con dirigenti qualificati e idonei direttamente impegnati nello svolgimento di determinati compiti, la giurisprudenza più recente sta confermando l'orientamento interpretativo per il quale il soggetto titolare dell'impresa non potrà rispondere dell'operato di quelli e, fornendo la prova di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità giuridiche (ottemperando in maniera diligente agli obblighi direttamente connessi al suo ruolo apicale) dovrà andare esente da responsabilità.
(Vietata la riproduzione)
Brevi cenni sull'invito a presentarsi : contenuto e limiti (Art. 375 c.p.p.)
Avv. Salvatore Scognamiglio 30.12.2017
Recita l'art. 375 c.p.p. che il Pubblico Ministero invita la persona sottoposta alle indagini a comparire dinanzi all'Autorità Giudiziaria in tutti i casi in cui la sua presenza è necessaria ai fini del compimento di determinati atti.
Trattasi pertanto di un atto posto in essere dal magistrato procedente con il quale la persona sottoposta ad indagini viene convocata presso gli uffici di polizia giudiziaria quando debbono essere espletate deteriminate attività d'indagine: il confronto, l'individuazione, l'interrogatorio e l'ispezione.
L'atto in oggetto deve tassativamente contenere l'indicazione delle generalità della persona e tutte le altre indicazioni personali idonee ad identificarla; l'ora, il giorno ed il luogo della comparizione; l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale deve presentarsi; deve altresì espressamente indicare il tipo di attività d'indagine che si andrà a porre in essere in sede di comparizione ( indicando l'atto specifico); ed infine, deve prevedere l'avvertimento espresso che, ove mai il destinatario dell'avviso non dovesse presentarsi senza addurre un legittimo impedimento ( debitamente documentato prima della scadenza del termine), il pubblico ministero procedente potrà discrezionalmente disporre l'accompagnamento coattivo del soggetto.
Va sottolineato che quando con l'invito la persona è chiamata a rendere interrogatorio, il P.M. contestualmente allo stesso, enuncia sommariamente il fatto per cui si procede secondo ciò che risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.
Rilevante è il rapporto tra invito a comparire e richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla nullità della richiesta quando essa non sia preceduta dall'invito ex art. 375 per rendere interrogatorio anche se un orientamento giurisprudenziale minoritario non condivide tale impostazione. E ciò sulla base dell'assunto che l'interrogatorio dinanzi al Gip esclude che si possa lamentare qualunque compressione delle garanzie difensive, in quanto il compimento di tale atto pone la persona sottoposta ad indagine nelle condizioni di esporre quanto utile alla propria difesa in relazione ai fatti-reato contestati (Trib. Milano 23.3.99 in Foro Ambrosiano Anno 1999, pag 317)
Peraltro, nei casi in cui risulti evidente la prova, l'autorità inquirente avverte l'indagato che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato ( procedimento penale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare, in maniera tale da pervenire direttamente alla fase dibattimantale subito dopo lo svolgimento delle indagini preliminari) .
L'invito a presentarsi deve essere comunicato al destinatario entro un determinato lasso temporale: esso dovrà essere notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per il compimento dell'attività d'indagine; detto termine, tuttavia, potrà essere abbreviato dal pubblico ministero per ragioni d'urgenza investigativa purché sia lasciato al destinatario dell'avviso lo spazio temporale materiale per comparire.
(Vietata la riproduzione)
Brevi cenni in tema di responsabilità penale dell'amministratore di condominio per omessa vigilanza e manutenzione dei beni comuni
Avv. Salvatore Scognamiglio 30.12.2016
Nell'odierna società è sempre più crescente la complessità degli incarichi e dei compiti che incombono sulla figura dell'amministratore di condominio e che lo rendono penalmente responsabile anche per omissione in tutti i casi in cui egli rivesta una posizione di garanzia nella vigilanza e corretta manutenzione dei beni comuni.
In tali casi la legge, prevedendo specifici obblighi di attivazione a suo carico, sancisce una responsabilità – a titolo di colpa o dolo – per non avere agito ponendo in essere la condotta dovuta.
Condotta che se fosse stata posta in essere avrebbe impedito l'evento o il verificarsi del pericolo.
Trattasi, pertanto, di responsabilità penale configurantesi nell'ipotesi di inerzia del soggetto attivo in tutti i casi in cui la normativa civilistica individua specifici compiti e doveri a carico dello stesso.
Dunque, ciò che legalmente si rimprovera al soggetto agente è di non essersi attivato – nei limiti della c.d. possibilità giuridica - al fine di scongiurare il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso che, in base ai principi fondanti tale responsabilità per omissione, equivale a cagionare l'evento, ai sensi del capoverso dell'art.40 del codice penale.
Con la sua colpevole inerzia, infatti, l'amministratore espone a pericolo la pubblica incolumità di tutti i soggetti che vengono in contatto con i luoghi e le pertinenze del condominio.
Tra le innumerevoli fattispecie che possono realizzarsi, quella più rilevante è certamente l'ipotesi prevista dall'art. 677 c.p. in tema di omessa vigilanza e manutenzione delle cose comuni, che punisce il proprietario ovvero chi per lui è obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell'edificio o della costruzione che nell'espletamento del mandato omette di provvedere ai lavori necessari per la rimozione del pericolo.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale l'agente deve agire sugli effetti e non sulla causa. L'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo, infatti, è del tutto scollegato dalla causa che lo ha determinato e pertanto è del tutto indifferente che la fonte dello stesso sia imputabile all'obbligato o che derivi da caso fortuito o forza maggiore.
Occorre infine rilevare che l'obbligo di attivazione in oggetto prescinde del tutto dal fatto che sia stato o meno formalmente notificato un atto amministrativo che certifichi la necessità di intervenire, poiché l'obbligo in esame deriva direttamente dalla legge.
E' ovvio che la figura in esame vada esente da responsabilità ogni qual volta sia stata la volontà dell'assemblea a non autorizzare l'intervento richiesto; nei limiti in cui, naturalmente, l'amministratore – se conosciuta la fonte di pericolo - dimostri che abbia fatto tutto quanto era in suo potere fino a quel momento, adottando i provvedimenti necessari ed urgenti e ponendo in essere le comunicazioni previste dalla legge. [Continua]
( Vietata la riproduzione)
Brevi cenni in tema di presupposti del provvedimento di sequestro preventivo (Art. 321 c.p.p.)
Avv. Salvatore Scognamiglio 23.12.2015
Il sequestro preventivo è un provvedimento giudiziario di natura provvisoria e cautelare emesso dal giudice competente su richiesta del pubblico ministero - ma quando non è possibile attendere il provvedimento del Gip il sequestro è disposto con decreto motivato dello stesso P.M.- in tutte le ipotesi in cui – come recita l'art.321 c.p.p. - vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito stesso.
Spesso i “non addetti ai lavori” confondono il sequestro di cui brevemente discorriamo con quello probatorio. In realtà essi, pur avendo il medesimo oggetto, perseguono scopi completamente diversi: infatti, mentre quello probatorio è diretto all'aquisizione delle prove, quello preventivo mira ad evitare che le conseguenze del reato si aggravino ( si pensi al caso oggi tristemente noto dei sequestri di discariche di rifiuti tossici) o siano protratte nel tempo ovvero che siano commessi altri reati.
Nel caso di sequetro disposto dalla polizia giudiziaria nel caso in cui non sia possibile attendere il provvedimento del P.M., gli ufficiali che lo eseguono devono trasmettere a quest'ultimo il verbale dell'atto entro 48 ore dal compimento dello stesso.
E' bene evidenziare che si applica anche al sequestro preventivo l'art. 259 c.p.p. in tema di custodia, con la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sottoposti al vincolo giuridico d'indisponibilità.
Due, pertanto, sono i presupposti indefettibili di tale provvedimento: il c.d. fumus delicti ed il periculum in mora.
Quanto al primo, è necessario cioè che si sia astrattamente verificato un fatto illecito che, dunque, del sequestro preventivo dovrà costituirne il fondamentale presupposto.
Il requisito del periculum in mora fa invece rifermento alla concreta possibilità ( mai eventuale o generica) che il bene sottoposto al vincolo di cui si discorre abbia chiaramente carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato.
Il pericolo - come giurisprudenza dominante va sostenendo - deve essere concreto, inteso cioè in senso oggettivo come probabilità di danno futuro.
Elementi la cui sussistenza il Pubblico Ministero deve attentamente valutare in sede di formulazione della richesta in esame.
Il sequestro può avere la durata massima di un anno, ma prima della scadenza può essere rinnovato se ne sussistono ancora i motivi giustificativi.
Potrà essere revocato su istanza del P.M. ( il quale, nel corso delle indagini preliminari, procede con decreto motivato, notificato a tutti i soggetti che hanno diritto di impugnazione) o di un interessato.
Oggetto del sequestro in esame può essere un bene mobile o immobile, una somma di denaro, la quota di una società , ecc.. ed ai fini che qui ci interessa, va richiamata la particolare ipotesi che si verifica in caso di bancarotta fraudolenta ex art. 216 legge fallimentare: qui, può operarsi il sequestro preventivo nell'ipotesi in cui la distrazione dei beni sia già stata consumanta e la cassazione ha ritenuto legittimo lo stesso anche prima che intervenga la sentenza dichiarativa del fallimento purché durante le indagini ricorrano gli indizi dello stato d'insolvenza [ continua].
(Vietata la riproduzione)
Brevi cenni sulla responsabilità penale del primario in caso di delega di funzioni
Avv. Salvatore Scognamiglio 16.05.2014
Avendo in questa sede precedentemente e sommariamente delineato l’istituto giuridico della “posizione di garanzia”, è ora opportuno riferire quella situazione giuridica alla figura del primario della struttura sanitaria.
Con tale espressione, cioè, si fa riferimento a quella serie di obblighi giuridici che incombono su tale importante figura professionale, ricoprendo il sanitario in questione - attesa soprattutto la delicatezza della funzione esercitata e la connessa responsabilità - una posizione apicale nell’ambito dell’attività medico chirurgica svolta all’interno della struttura di cui è parte.
La giurisprudenza, sulla stessa linea di pensiero della dottrina dominante, statuisce che il primario, a prescindere dalla natura pubblica o privata del nosocomio nel quale va ad operare, non può mai escludere la propria responsabilità adducendo come supposta causa scriminante che, ad esempio, al reparto fossero stati assegnati altri sanitari o che - addirittura - in quel dato contesto storico ed operativo in cui si è prodotto l’evento lesivo per il bene salute del degente, il medico non fosse presente all’interno della struttura sanitaria.
In base ai principi fondanti la “posizione di garanzia” non solo il primario con la sua condotta non deve produrre direttamente l’evento lesivo in ossequio ai canoni generali della colpa professionale, ma deve altresì sempre attivarsi affinché i pazienti non subiscano lesioni per effetto delle condotte errate od omissive poste in essere dagli altri medici ( sottoposti al primo) della struttura, con ciò configurandosi chiaramente un vero e proprio obbligo giuridico di vigilanza.
In caso contrario si configura in capo al primario – come già anticipato a suo tempo – un reato omissivo improprio per non avere impedito, ai sensi del capoverso dell’art. 40 del codice penale, il verificarsi dell’evento di danno, non attenendosi lo stesso ai canoni di diligenza che era obbligato ad osservare.
Il primario, dunque, svolge la sua funzione in veste di vero e proprio garante in senso tecnico e la sua responsabilità potrà configurarsi quando si siano realizzati i tre fondamentali presupposti in tema di omissione: 1) Quello della violazione dell’obbligo giuridico di attivarsi nella fattispecie concreta in base, ovviamente, ai canoni della possibilità giuridica; 2) Quello del nesso eziologico tra condotta omissiva ed evento lesivo; 3) Quello, infine, della colpa, ascrivibile all’agente quando, nella fattispecie concreta realizzata, egli non si sia uniformato alle regole all’uopo predisposte ( ad esempio le c.d. linee guida).
Il profilo che in questa sede preme mettere in rilievo è quello riguardante la responsabilità del garante-primario nel caso di delega di funzioni.
Sulla questione, che - prima facie- per i “non addetti ai lavori” potrebbe apparire come non controversa, si è in realtà acceso un lungo ed intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che ha infine fornito una serie di spunti importanti relativamente all’interpretazione corretta dei limiti della delega.
Proprio in ragione del ruolo apicale ricoperto e la complessità della funzione svolta, il primario-garante può delegare, nel rispetto di determinati limiti, talune e specifiche attività, gestendo in maniera adeguata la distribuzione dei compiti.
I criteri di scelta del delegato devono essere il più possibile predeterminati e tali da consentire di tutelare al massimo la vita del paziente evitandogli rischi per la sua salute, anche se va sottolineato l’importante dato che il legislatore non ha ancora, a tutt’oggi, elaborato e tipizzato in maniera precisa e compiuta il contenuto della delega.
La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che egli, pur quando abbia verificato in astratto la presenza dei requisiti e delle capacità tecniche del potenziale medico – delegato, debba successivamente ed obbligatoriamente appurare che quest’ultimo possieda effettivamente le abilità tecniche richieste nel caso specifico in maniera tale da poter svolgere correttamente la mansione assegnatagli.
In caso contrario il titolare della posizione apicale ( posizione di garanzia) risponde di culpa in eligendo per una errata e/o inidonea scelta del preposto, avendo operato in modo negligente la valutazione in merito alle concrete e specifiche capacità del delegato-medico.
Ovviamente, come già accennato, il primario dovrà andare esente da responsabilità in tutti i casi in cui egli abbia dato la prova – non sempre facile da fornire- dell’avvenuta, preliminare valutazione in concreto dell’esistenza dei requisiti tecnici e delle abilità pratiche del delegato.
( Vietata la riproduzione)
Brevi cenni in tema di colpa professionale medica:la persona offesa quale anello debole del procedimento penale
Avv. Salvatore Scognamiglio 31.07.2013
La letteratura giuridica avente ad oggetto i casi di malasanità prodottasi dalla metà degli anni ’90 ad oggi mostra un dato inesorabile e triste: la persona offesa nei procedimenti penali per colpa medica costituisce una figura giuridica non degnamente tutelata nel nostro sistema giudiziario processualpenalistico.
E’ paradossale pensare che, ancora oggi, il sistema giuridico nostrano - nonostante l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni abbia raggiunto livelli di analisi molto elevati - non riesca ancora a garantire alla persona offesa dal reato nei procedimenti a carico dei sanitari, una serie di strumenti -che oserei definire “minimi”-, in grado di rendere effettivamente incisivo il ruolo della stessa nella fase delle indagini preliminari ed in particolare che siano in grado di poter valorizzare in maniera effettiva la funzione tecnica esercitata dal medico legale quale consulente di parte.
Molteplici sono i profili sul tema che devono essere ancora approfonditamente scandagliati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma in questa sede mi limiterò ad accennare ad uno solo di essi: la valutazione operata dal giudice delle indagini preliminari sul lavoro scientifico svolto dal consulente di parte nominato dalla P.O.
Per inquadrare immediatamente i termini della questione partirei da una domanda: per quale ragione, ci si chiede, il lavoro svolto dal Consulente di parte viene spesso considerato “figlio di un Dio minore”?
Per quale motivo, cioè, il lavoro scientifico del Ctp poi trasfuso nelle note tecniche, non debba avere pari dignità di quello del Consulente tecnico d’ufficio.
La significativa elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni dimostra, senz’ombra di dubbio, che alla base di questo – diciamo così- diverso approccio del giudice al tema, ci sono diversi fattori, tutti in egual misura determinanti nella valutazione finale del magistrato giudicante (Leggi: archiviazione).
Uno, in particolare, però, secondo l’opinione dello scrivente, pare assorbire tutti gli altri: il condizionamento (inevitabile?) psicologico che il lavoro scientifico del consulente nominato dal P.M. poi riversato nella Relazione d’ufficio depositata all’esito delle indagini, può produrre sulle determinazioni del Giudice.
Ed infatti, molto spesso la prassi giurisprudenziale dimostra che, anche quando la persona offesa si sforzi generosamente, sin dall’avvio delle indagini preliminari ( con la presenza non “passiva” dei consulenti di parte all’esame autoptico del paziente deceduto) di fornire una adeguata ed incisiva collaborazione medico-scientifica, sia le valutazioni finali del Pubblico Ministero che quelle del Gip, paiono chiaramente “appiattirsi” sulle considerazioni tecniche del CTU, anche quando queste ultime palesano evidenti punti critici.
Non è condivisibile, e non dovrebbe mai accadere, ad esempio, che in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dal P.M., il Giudice, lungi dal considerare giuridicamente apprezzabile il contributo medico scientifico del consulente medico legale di parte, non si pronunci sulle eccezioni tecniche formulate da quest’ultimo e ritenendo senz’altro ed apoditticamente accoglibili le considerazioni proposte dal CTU.
Cosa che risulta essere ancora più censurabile quando l'oggetto dell'ipotesi di reato da verificare richieda inevitabilmente la verifica preliminare del rispetto delle c.d. linee - guida, ossia quell'insieme di regole che indicano il modus procedendi nella diagnosi e nella terapia delle diverse e sempre più complesse patologie moderne.
Per cogliere pienamente l'importanza delle linee-guida (e dei protocolli, che altro non sono che linee-guida altamente dettagliate) e la connessa, fondamentale valutazione che il giudice - con il contributo dei consulenti delle parti - va ad operare sulle stesse, si pensi al noto caso ( Cass. pen. n°16995/2006) in cui è stata affermata la responsabilità penale del ginecologo per aver provocato per colpa la morte di una paziente per arresto cardiaco a seguito di shock emorragico, atteso che, a giudizio della Suprema Corte, il sanitario in questione non aveva proceduto in conformità ai protocolli medici che prevedevano una determinata attività medica che, invece, non fu mai eseguita : c.d. raschiamento dell'utero e, in caso di esito negativo, terapia a base di somministrazione di uterotonici; infine, come extrema ratio, l'isterectomia ( asportazione chirurgica). (continua)
( Vietata la riproduzione)
Brevi cenni in tema di reato di atti persecutori (Stalking)
Avv. Salvatore Scognamiglio 31.10.2012
Recita l’art. 612 bis del codice penale italiano: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni“.
La definizione di Stalking trae origine dal termine anglosassone “ to stalk” ( “fare la posta”) e indica una serie di comportamenti ( integranti appunto gli atti persecutori) posti in essere da un soggetto ( c.d. stalker, nella maggior parte dei casi, un soggetto maschile) nei confronti della vittima, al fine di ingenerare in quest’ultima uno stato di ansia, paura, angoscia e che compromettono gravemente ed in maniera permanente la sua qualità di vita.
Pertanto, la condotta criminosa in esame si realizza con la mera reiterazione di minacce o molestie da parte del soggetto attivo, quando si abbia il fondato timore che sia in grave pericolo l’incolumità psichica della vittima - senza che sia necessario che si configuri un danno biologico - o di un suo prossimo congiunto o quando sia gravemente messa in pericolo la sicurezza personale dei soggetti passivi della fattispecie.
La letteratura pacificamente concorda nel ritenere che la minaccia o le molestie devono essere credibili e deve trattarsi di un pericolo incombente.
E’ tuttavia ancora dibattuto in giurisprudenza quale sia il criterio da adottare da parte del giudice nella valutazione dell’elemento della “reiterazione” delle condotte in oggetto: qualitativo ( basato sull’abitualità del comportamento, dovendo quest’ultimo trarre origine da un medesimo disegno criminoso che collega le – anche se poche - azioni , pur apparendo queste ultime all’esterno come isolate) o quantitativo ( in base al quale, per potersi parlare di condotte reiterate, deve necessariamente realizzarsi una serie prolungata di atti integranti la fattispecie incriminatrice).
Per procedere è necessaria la querela della persona offesa, da proporre tuttavia entro un termine decisamente più lungo rispetto a quello ordinario: 180 giorni dalla realizzazione dell’illecito o, meglio, dal compimento dell’ultimo della serie di atti persecutori.
Tuttavia, in tre ipotesi ben precise è possibile procedere d’ufficio: 1) anzitutto, quando il soggetto sia stato precedentemente ammonito con procedura attivata dal Questore ex art. 8 D.L. 11/09, poi convertito nella L. 38/2009; 2) Quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore o di una persona affetta da disabilità; 3) In tutti i casi in cui la fattispecie criminosa integrante lo stalking sia collegata ad altri reati per cui si debba procedere d’ufficio.
Dunque, la condotta realizzativa degli “atti persecutori” ex art. 612 bis c.p. deve necessariamente consistere in una serie di comportamenti vessatori integranti forme manifeste di minacce, molestie e atti lesivi; essi debbono essere reiterati nel tempo e devono indurre nella vittima un disagio psichico e fisico senza che sia necessario da parte dell’interprete ( in primis, il giudice) accertare che sia stato cagionato un danno sotto il profilo biologico, essendo sufficiente appurare che il normale equilibrio psico-fisico del soggetto passivo sia stato – anche se solo parzialmente- alterato. ( continua)
( Vietata la riproduzione)
Brevi cenni sulla Libertà vigilata: presupposto, funzione, contenuto e limiti applicativi
Avv. Salvatore Scognamiglio 02.06.2012
La libertà vigilata è la principale misura di sicurezza personale non detentiva prevista dalla legge, la cui inflizione da parte del giudice comporta, da un lato, l’osservanza di una serie di prescrizioni che limitano la libertà personale del soggetto che ne è colpito; dall’altro, consentendo al sottoposto alla M.S. il suo riadattamento sociale mediante il lavoro.
Presupposti della sua applicazione, pertanto, sono la sussistenza oggettiva di una delle ipotesi c.d. di “ quasi reato” ( artt. 49 e 115 del c.p.) quando sia accertata dal giudice la volontarietà del comportamento criminale ed il requisito della pericolosità sociale.
Funzione di tale misura coercitiva, infatti, è innanzitutto quella di impedire che il soggetto socialmente pericoloso possa reiterare il reato e quella, forse ancora più importante, di promuovere il reinserimento sociale dello stesso, in ossequio all’art. 27, 3° comma, della Costituzione, per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Recita l’art.228 del codice penale che la sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’Autorità di pubblica sicurezza e che le prescrizioni impartite dal giudice ( competente è, in determinati casi, il giudice che infligge la condanna, in altri il Magistrato di sorveglianza in sede di primo esame o riesame della pericolosità sociale del condannato, restando sempre ferma la competenza di quest'ultimo quando occorre specificare la prescrizione impartita) possono essere successivamente modificate o limitate, sia in melius che in peius, così da poter adeguare il contenuto prescrittivo della misura al grado effettivo di pericolosità del soggetto, assumendo come parametro i progressi o i regressi compiuti .
Essa non può avere durata inferiore ad un anno. La durata è invece di tre anni nell’ipotesi in cui viene inflitta la reclusione per non meno di dieci anni e quando, a seguito di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena dell’ergastolo.
Quanto al contenuto della libertà vigilata ci si attiene alla discrezionalità del giudice, essendo espressamente previsti dal codice di procedura penale soltanto gli obblighi di rendersi reperibile per la consegna della c.d. carta precettiva (che contiene la trascrizione delle prescrizioni impartite), di presentarla a richiesta del pubblico ufficiale; di non trasferire, senza l’autorizzazione del magistrato, la propria residenza o dimora in un comune diverso e di informare immediatamente l’autorità giudiziaria di ogni mutamento – anche se modesto- di abitazione nell’ambito del comune.
Un cenno va fatto alla possibilità, per il soggetto che vi è sottoposto, di poter impugnare, ai sensi dell’art. 680 c.c.p., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che respingano eventuali richieste di autorizzazioni ( ad es., quella di allontanarsi dal comune di residenza per ragioni di lavoro).
Competente a decidere quale giudice del gravame è il Tribunale di sorveglianza.
Nell’ipotesi di violazione degli obblighi imposti con la misura di sicurezza, il giudice può aggiungere la cauzione di buona condotta o, se vi è impossibilità economica a prestarla o se le trasgressioni sono gravi e ripetute nel tempo, può – come ipotesi estrema – sostituire la libertà vigilata con la misura della colonia agricola o la casa di lavoro, con evidenti effetti peggiorativi per la qualità della vita del sottoposto, attesa la natura certamente più afflittiva delle misure citate.
( Vietata la riproduzione)
Brevi cenni sull'applicazione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per abuso edilizio.
01.11.2011 Avv. Salvatore Scognamiglio
In tema di costruzione abusiva, nel nostro sistema giuridico operano contemporaneamente due azioni finalizzate al ripristino della situazione quo ante : da un lato, quella amministrativa avviata ad esempio dal comune sul cui territorio insiste il manufatto abusivo, con la emissione del provvedimento con cui si ordina la demolizione dell’opera; dall’altro, l’azione penale del magistrato del Pubblico Ministero, tenuto ad accertare tutti gli eventuali profili di responsabilità penale della condotta posta in essere dal soggetto autore della fattispecie.
Avverso il provvedimento amministrativo il destinatario può ricorrere entro sessanta giorni al Tar territorialmente competente chiedendo, contestualmente all’annullamento dell’atto e sempre che ne ricorrano i presupposti - come nell’ipotesi abbastanza frequente di costruzione destinata ad essere unica abitazione dell’autore del reato - che il Giudice amministrativo pronunci ordinanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento stesso in attesa del giudizio di merito.
Tuttavia può benissimo accadere – come in effetti spesso accade- che arrivi a conclusione prima il processo penale: in tal caso il Giudice, ai sensi dell’art. 7 L. 47/ 1985 ( T.U. Edilizia) nel pronunciare la (eventuale) sentenza di condanna inserisce nel corpo di questa anche l’ordine di demolizione dell’opera abusiva.
In mancanza di ottemperanza spontanea ( che peraltro comporta indubbiamente minori costi per l’obbligato) sarà lo stesso P.M. a provvedere alla sua esecuzione, chiedendo finanche l’intervento del Genio civile e l’assistenza della forza pubblica.
Ciò che interessa in questa sede mettere in evidenza è che - come consolidato orientamento giurisprudenziale ha oramai più volte ribadito – in caso di condanna penale per il reato di cui al Testo Unico edilizia, il Giudice può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva all’effettiva esecuzione dell’obbligo di abbattimento del manufatto abusivo.
Il beneficio in esame, infatti, ai sensi dell’art. 165 del codice penale può essere subordinato alla “ effettiva eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”.
Ed è evidente l’effetto persuasivo che la corretta applicazione della norma può avere sul condannato, posto davanti all’alternativa di conservare il bene abusivamente realizzato espiando la pena detentiva, e quella di abbattere spontaneamente il manufatto evitando l’applicazione della pena stessa.
Va sottolineato che il principio in esame trova applicazione anche nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 C.P.P. ( c.d. patteggiamento) atteso che l’ordine di abbattimento non costituisce pena accessoria ai sensi dell’art. 445 comma primo C.P.P. ma sanzione di natura amministrativa: non potendo costituire quindi oggetto di “accordo” tra P.M. ed imputato, il giudice penale, anche in quest’ipotesi, può pacificamente non concedere il beneficio della sospensione, essendo assolutamente carente il presupposto del ripristino dello status quo ante da parte dell’autore della condotta criminosa, ossia l’esecuzione effettiva dell’abbattimento.
( vietata la riproduzione)
Brevi cenni sull’adozione del minore: natura, requisiti e limiti.
16.10.2011 Avv. Salvatore Scognamiglio
In armonia con i principi dettati dalla fondamentale Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge n° 176 del 21 maggio 1991, l’istituto dell’adozione si caratterizza chiaramente nell’odierno ordinamento giuridico italiano come diritto del minore ad avere una famiglia, intesa quest’ultima quale luogo in cui la persona umana possa sviluppare pienamente la propria personalità, ricevendo l’educazione e la cura all’uopo necessarie.
Non è casuale, infatti, che la materia de quo, trattata dalla L. 149 del 28 marzo 2001 (che ha riformato la precedente legge n°184 del 1983) rechi, al Titolo primo, la locuzione “ Diritto del minore ad una famiglia”.
Dunque, l’attuale concezione dell’istituto dell’adozione costituisce il risultato di una lunga evoluzione dottrinale che ha fatto proprie le istanze riformatrici e solidaristiche di altri ordinamenti giuridici europei i quali ponevano già da tempo al centro dell’attenzione non già la classica figura della famiglia adottiva, ma quella del minore che ne sia privo o che non ne abbia una idonea.
Prima di entrare nel merito della normativa in oggetto va fatta una premessa fondamentale.
L’adozione, come espressamente sancito nell’art. 1 della L. 184, deve costituire in ogni caso l’extrema ratio, dovendosi considerare come un rimedio eccezionale, che trova applicazione solamente nelle ipotesi in cui siano risultati del tutto inutili gli strumenti giuridici finalizzati alla tutela e conservazione dell’ambiente familiare d’origine: compito, quest’ultimo, demandato in particolar modo agl’Enti locali, i quali debbono approntare tutti gli strumenti economico-sociali per sostenere i c.d. nuclei familiari ad alto rischio.
Presupposto fondamentale perché si possa procedere all’adozione del minore è la dichiarazione dello stato di adottabilità ad opera del tribunale per i minorenni a cui, successivamente, seguirà il c.d. affidamento preadottivo; dichiarazione che ricorre quando il bambino si trovi in condizioni di “ abbandono”, ossia nell’ipotesi di omessa assistenza morale e materiale da parte dei genitori e di tutti i parenti più prossimi che vi erano obbligati per legge.
Ed il presupposto dell’abbandono non va assolutamente legato all’esistenza o meno di una “colpa” dei genitori d’origine; infatti, la condizione di grave disagio economico, materiale e morale del minore – come dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono- si configura per il solo fatto oggettivo dell’esistenza di tale situazione fattuale, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza o meno di una precisa e consapevole “ volontà” in tal senso degli obbligati.
Come sopra accennato, competente a decidere lo stato di adottabilità è il tribunale per i minori, il quale - su segnalazione esterna degli organi a ciò preposti o d’ufficio - procede agli accertamenti tecno-scientifici necessari e dopo un lungo e alquanto tortuoso iter burocratico, accertato che la condizione di abbandono ha assunto un carattere irreversibile, pronuncia con sentenza la dichiarazione in oggetto.
E ciò avviene quando i genitori d’origine ed i parenti, sentiti dal tribunale e valutati tutti gli elementi raccolti, non siano riusciti a fornire la prova che la situazione di abbandono non sia più esistente e, in ogni caso, quando tutte le prescrizioni impartite nel corso del procedimento non siano state adempiute dagli obbligati indicati dal giudice, salvo quest’ultimi non forniscano la prova di un giustificato motivo che abbia costituito grave impedimento al corretto soddisfacimento degli “ordini” del tribunale.
Come detto, alla dichiarazione in esame segue l’affidamento preadottivo alla coppia ritenuta idonea ( cioè deve trattarsi di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto, capaci – anche economicamente- di educare, curare, istruire e far sviluppare in maniera dignitosa la vita del fanciullo; la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni; uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni purché sia comunque inferiore ai 55): una sorta di “adozione provvisoria’’della durata di almeno un anno che si ottiene con provvedimento del tribunale quando il minore che abbia compiuto i dodici anni ( anche prima se sussiste una valida “capacità di discernimento” dello stesso) venga sentito in un’apposita audizione e ritenuto bisognevole della stessa.
Unico limite al regime dell’affidamento preadottivo è che il minore interessato al provvedimento abbia altri fratelli, salvo però che g
Che cos’è la riabilitazione: requisiti e limiti 24.12.2010 Avv. Salvatore Scognamiglio
La riabilitazione è una causa di estinzione prevista dal nostro ordinamento giuridico che provoca la cessazione delle pene accessorie e di tutti gli altri effetti penali che conseguono alla condanna inflitta dal giudice, fra cui, ad esempio, quello della cancellazione del reato dal casellario giudiziario, certamente il più rilevante per il condannato nell’ottica del suo futuro reinserimento sociale.
Il beneficio in esame è concesso quando sia trascorso un certo lasso di tempo dal giorno di inflizione della pena principale e nell’ipotesi in cui il condannato abbia dato prova, attraverso la sua condotta penitenziaria, di sicuro ravvedimento.
Recita l’art.179, 1° c. c.p.( nella versione modificata dall’art. 3 lett. a della l. 11.06.2004 n° 145): La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta,e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Dunque, la ratio della norma, secondo la dottrina dominante, consisterebbe essenzialmente nel consentire al condannato il suo reinserimento sociale, in ossequio ai principi fondamentali di rieducazione del reo ex art. 27, 3° c. della Costituzione.
Il provvedimento può essere adottato solo su richiesta dell’interessato e competente a decidere è il Tribunale di sorveglianza del distretto di Corte d’Appello nell’ambito del quale è stata comminata la condanna.
La concessione della riabilitazione non può essere disposta quando il condannato sia sottoposto a misura di sicurezza ( salvo il caso della m.s. dell’espulsione dello straniero e quello della confisca ) o quando lo stesso non abbia ancora provveduto alle restituzioni, alla riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna e al rimborso allo Stato delle spese di mantenimento ( salvo che l’interessato non provi la sua assoluta impossibilità di adempiere).
Il regime ordinario relativo ai requisiti per l’ottenimento del beneficio subisce alcune eccezioni: anzitutto, il termine passa da tre a otto anni nei casi di recidiva aggravata, di recidiva reiterata e nei casi di recidiva obbligatoria; ed inoltre, nei casi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, il termine necessario è di dieci anni e decorre dal momento in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione a una colonia agricola o alla casa lavoro.
Va sottolineato che le eventuali condanne successive per fatti posteriori a quelli per cui è stata presentata l’istanza di riabilitazione non costituiscono impedimento alla concessione della stessa.
Il problema più dibattuto nella letteratura relativa all’istituto in oggetto è certamente quello concernente l’ esatta interpretazione del requisito della buona condotta del detenuto.
A tal proposito la dottrina dominante e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che possa parlarsi correttamente di comportamento integrante una buona condotta riabilitativa nell’ipotesi in cui il condannato – lungi dal dover dimostrare un pentimento sotto il profilo morale, come pure certa giurisprudenza ha fatto- ponga in essere, nell’arco temporale utile, una condotta che non abbia mai violato norme penali integranti fattispecie della stessa natura di quello per cui è stata pronunciata la condanna e, in ogni caso, quando non abbia mai commesso reati non bagatellari.
Il beneficio viene revocato a seguito di delitto non colposo commesso entro sette anni dalla sentenza definitiva che lo ha disposto a condizione che per il nuovo reato sia applicata una pena pari o superiore a due anni oppure l’ergastolo.
Chi è l’agente provocatore e quando è lecita la sua attività
30.04.2008 Avv. Salvatore Scognamiglio
L’agente provocatore è il soggetto – pubblico ufficiale o privato cittadino – che istiga un terzo a commettere un reato al solo scopo di far scoprire quest’ultimo prima che il delitto arrivi a consumazione.
La ratio dell'istituto andrebbe ravvisata, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dominante, nel generale dovere di non contraddizione: l’ordinamento giuridico imponendo, da un lato, una determinata condotta, non può, dall’altro, farne derivare la punibilità.
Una delle ipotesi normativamente previste è quella ex art. 97 D.P.R. 309/90 con riferimento a chi – appartenente alle forze dell’ordine- procede all’acquisto di sostanze stupefacenti al fine di acquisire elementi di prova in relazione a quei reati riguardanti il traffico ed il commercio di sostanze stupefacenti.
Così sommariamente definita la figura dell’agente provocatore, ci si chiede in base a quali criteri egli debba andare esente da responsabilità e quando, invece, egli risponda a titolo di partecipazione concorsuale nel reato commesso dal soggetto provocato - cioè da colui che è istigato alla commissione del fatto – nel caso di consumazione.
Per rispondere a questo quesito occorre avere riguardo – secondo un certo orientamento - alla rilevanza causale della condotta: l’agente provocatore va esente da responsabilità se il suo è stato un ruolo indiretto e marginale nella commissione del reato, essendosi la condotta concretizzata in una mera attività di controllo, monitoraggio e contenimento dell’altrui azione illecita; viceversa, egli risponde a titolo di concorso se, attraverso la sua condotta, ha posto in essere un’attività rilevante nell’ideazione e consumazione del delitto commesso dal provocato.
Pertanto, ciò che caratterizza tale figura è l’assenza del dolo, nel senso di mancanza della volontà di partecipazione: ciò che vuole e si rappresenta l’agente provocatore non è la realizzazione di un reato da parte di terzi, ma un mero tentativo inidoneo, confidando nel fatto che la consumazione sarà impedita da cause esterne, prima fra tutte, da un’azione interruttiva posta in essere dalle forze dell’ordine.
Sul punto, la dottrina più autorevole ( Mantovani, Diritto penale) è più rigida nella costruzione del dolo, ritenendo che l’agente provocatore vada esente da responsabilità quando egli abbia agito non accettando neppure il rischio che il reato si realizzi; deve, dunque trattarsi di dolo di tentativo e non di consumazione.
Minoritaria è invece la teoria (del Fiore) che individua il fondamento dell’istituto in esame, nell’azione socialmente adeguata, per la quale la condotta del provocante si giustificherebbe perché posta in essere per raggiungere specifiche finalità perseguite dalla comunità.
Questa tesi non trova ormai accoglimento nella letteratura dominante e nella giurisprudenza più recente: in effetti il fine proprio dell’ordinamento non è quello della repressione dei reati provocati da pubblici ufficiali.
L’agente provocatore, dunque, solo in apparenza partecipa alla commissione di un reato, avendo egli, in realtà, come unico obiettivo, quello di farne scoprire i responsabili.
Tuttavia, altra autorevole dottrina ( Marinucci-Dolcini Diritto Penale) ritiene che la scriminante dell’adempimento del dovere ex art 51 c.p. possa essere utilizzata solo con riferimento al c.d. infiltrato, cioè dell’agente delle forze dell’ordine che, agendo”sotto copertura”, si inserisce all’interno di organizzazioni criminali , compiendo reati per acquisire elementi di prova a carico degli associati.
La giurisprudenza, a tal proposito richiama il disposto normativo dell’art. 55 c.p.p., in base al quale la polizia giudiziaria ha sempre l’obbligo di ricercare le prove ed assicurare i colpevoli alla giustizia.
Per capire, invece se e quando il provocato risponda del reato, occorre valutare in quali termini si pone il contributo causale del provocante nei suoi confronti: in altre parole, la sua punibilità sarà esclusa solo quando, ex post, la condotta del primo, venga valutata come non determinante e del tutto indipendente dalla sua condotta, nel senso che il provocato ha agito in condizione di non dipendenza assoluta e diretta della condotta dell’agente provocatore.
( vietata la riproduzione)